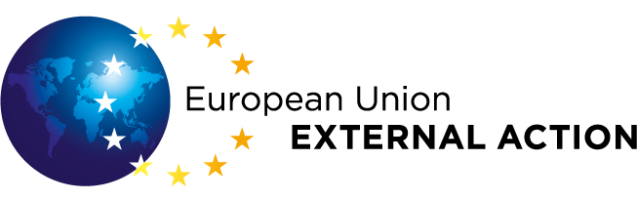Quo vadis, Europa?

"Se l'Europa vuole svolgere un ruolo chiave nel plasmare il mondo post COVID‑19, dobbiamo rafforzare la nostra coesione interna e dialogare più efficacemente con tutte le regioni del mondo."
Santander è la capitale della regione Cantabria, sulla costa settentrionale della Spagna. Durante la Seconda repubblica spagnola, nel 1932 in questa città è stata fondata un'università internazionale, con sede nell'ex palazzo reale di La Magdalena, affinché la Spagna si aprisse alla cultura e alla scienza del resto del mondo. Nel 1975, quando in Spagna è tornata la democrazia, il palazzo ha nuovamente ospitato l'Università internazionale Menendez Pelayo (UIMP), e dal 2001, anno in cui ho partecipato alla Convenzione europea, vi si tiene un seminario di una settimana, da me diretto, dedicato ai principali temi rilevanti per il futuro dell'Europa. Il titolo del seminario è Quo vadis, Europa? ed è divenuto un appuntamento imprescindibile per il dibattito e la riflessione sull'Europa durante la pausa estiva.
Le riflessioni approfondite assieme agli esperti e gli interrogativi delle giovani generazioni
Quest'anno ci siamo concentrati su come si possa costruire un'Europa geopolitica. L'edizione del 2021 mi ha offerto l'opportunità preziosa di prendermi una breve pausa dalla pressione delle crisi quotidiane per riflettere in modo approfondito assieme ad esperti provenienti da tutto il mondo e ascoltare gli interrogativi e le preoccupazioni dei giovani provenienti dall'Europa e dall'estero. In questo post del mio blog voglio concentrarmi sulle principali conclusioni emerse da questo evento produttivo e stimolante.
Nella sessione di apertura, con il mio amico Enrico Letta (ex presidente del Consiglio italiano e attualmente segretario del Partito democratico), Nathalie Tocci (IAI) e Jose Ignacio Torreblanca (ECFR) ci siamo concentrati sulle sfide di un mondo post COVID‑19 e sul ruolo dell'Europa in tale contesto. Dopo questa crisi, il mondo sarà probabilmente più digitale, più asiatico e più diseguale. E senza dubbio sarà anche più multipolare e conflittuale. Ma richiederà anche un maggiore multilateralismo, in particolare in materia di salute e clima. Se l'Europa vuole svolgere un ruolo chiave nel plasmare questo mondo, deve rafforzare la sua coesione interna e collaborare più efficacemente con tutte le regioni del pianeta, al di là del nostro vicinato più prossimo.
"Se l'Europa vuole svolgere un ruolo chiave nel plasmare il mondo post COVID‑19, deve rafforzare la sua coesione interna e collaborare più efficacemente con tutte le regioni del pianeta."
Secondo Enrico Letta è sia per via della Brexit che del mutato atteggiamento della Germania nei confronti dei suoi partner rispetto alla crisi finanziaria del 2008-2011 che siamo riusciti ad approvare assieme il piano NextGenerationEU, uno dei maggiori risultati ottenuti finora dalla Commissione europea. Ma per rafforzare efficacemente la coesione dell'Europa molto dipenderà dalla qualità della sua attuazione, soprattutto in paesi come Italia e Spagna: come sottolineato da Letta, questi due paesi riceveranno quasi il 40 % dei finanziamenti di NextGenerationEU. L'attuazione sarà determinante per ripetere interventi condivisi di questo tipo, che Letta ritiene indispensabili, conferendo loro in futuro una dimensione più genuinamente transnazionale.
Abbiamo proseguito la discussione sull'attuazione di NextGenerationEU e su cosa rappresenti in particolare per la Spagna assieme ai rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte: la Commissione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri spagnola, il Parlamento europeo e la regione Cantabria. Le discussioni si sono concentrate sul rigore indispensabile nell'attuazione dei progetti finanziati da NextGenerationEU e sulle riforme da attuare al contempo. Questa iniziativa non è soltanto uno strumento anticiclico per far fronte alla pandemia, ma soprattutto un modo per preparare il futuro, per "ricostruire meglio".
"NextGenerationEU non è solo uno strumento anticiclico per far fronte alla pandemia. È un modo per preparare il futuro, per "ricostruire meglio""
Gli oratori intervenuti hanno evidenziato la qualità del dialogo su questo tema tra il governo spagnolo e la Commissione europea, come anche le notevoli differenze da questo punto di vista rispetto a quanto avvenuto durante la crisi della zona euro dieci anni fa. Un interrogativo importante, tuttavia, rimane senza risposta in questa fase: come dovrebbero essere applicate le regole di bilancio dopo la crisi e come dovrebbero evolvere? Certamente, le regole pre-crisi sono diventate di fatto inapplicabili a causa del livello raggiunto dal debito pubblico. Su questo tema dobbiamo avviare un dibattito aperto, che non sarà facile, ma sarà importante per il futuro dell'Europa.
Non è sufficiente fare da normatore
In un'altra sessione, il mio collega Thierry Breton ha presentato le sfide connesse all'autonomia strategica dell'UE nel settore della tecnologia e l'azione della Commissione europea in questo ambito. Abbiamo discusso questo tema con esperti quali Anu Bradford (autore del libro "Effetto Bruxelles"). Dobbiamo certamente rafforzare il nostro potere di "normatore", che rimane un punto di forza fondamentale dell'UE. Ma gli oratori hanno anche sottolineato che dobbiamo investire molto di più insieme nel settore dell'alta tecnologia. NextGenerationEU ci consentirà di farlo.
"L'UE è l'attore globale che integra maggiormente i diritti umani nella sua politica estera e le sanzioni dell'UE nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni dei diritti umani hanno un impatto tangibile."
Abbiamo poi discusso la questione dei diritti umani con Michelle Bachelet (Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani), che ha descritto la difficile situazione su questo fronte a livello mondiale. L'UE è senza dubbio l'attore globale che integra maggiormente i diritti umani nella sua politica estera e il fatto che l'UE possa imporre sanzioni nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni dei diritti umani è significativo ha un impatto tangibile. Questo potere è stato ulteriormente rafforzato grazie all'adozione, nel 2020, di un nuovo regime globale di sanzioni. Ma sussistono ancora spesso contraddizioni tra i valori e gli interessi dell'UE. Gli oratori hanno sottolineato che tale discrepanza rimane difficile da gestire nelle nostre relazioni con le principali potenze mondiali. E da parte mia posso testimoniare che le occasioni di constatarlo nel mio lavoro quotidiano non mi mancano! Nessuno si adopera più dell'UE per la difesa dei diritti umani, ma ci viene chiaramente chiesto di fare ancora di più.
Diritti umani e commercio
Abbiamo discusso di come si possa allineare meglio i nostri interessi e i nostri valori. Ciò può essere opportuno in particolare nel settore degli accordi commerciali: la difesa dei diritti sociali e ambientali a livello globale contribuisce a sostenere i nostri produttori. A tale proposito è stata sottolineata l'importanza della futura direttiva sul dovere di diligenza per le società multinazionali, che indurrà tutti i soggetti privati coinvolti ad assumersi le proprie responsabilità in tale ambito. Abbiamo inoltre discusso la difficile questione dell'asilo e della migrazione posta dal filosofo politico Saim Nair. Ho sottolineato che dobbiamo naturalmente ottemperare a tutti i nostri obblighi in materia di asilo, agendo nel modo più umano possibile e coordinando meglio le nostre azioni. Per porre in atto un regime di migrazione che funzioni dobbiamo combattere i trafficanti di esseri umani ma anche creare vie di migrazione legali e aumentare gli investimenti, la cooperazione e gli aiuti allo sviluppo assieme ai nostri partner, in particolare in Africa.
"Per porre in atto un regime di migrazione che funzioni dobbiamo certamente combattere i trafficanti di esseri umani ma anche creare vie di migrazione legali e aumentare gli investimenti, la cooperazione e gli aiuti allo sviluppo assieme ai nostri partner, in particolare in Africa."
Una sessione molto interessante è stata quella dedicata al futuro del multilateralismo in un mondo dove cresce l'anarchia. La situazione è certamente difficile da questo punto di vista, ma le prospettive sono probabilmente meno desolanti di quanto possa sembrare - come dimostra, ad esempio, l'accordo sulla tassazione delle società multinazionali raggiunto nel quadro dell'OCSE e del G20. La questione dei cambiamenti climatici e la COP 26 di Glasgow del prossimo novembre saranno decisive a riguardo. Certamente l'UE continuerà a sostenere con tutte le sue forze il consolidamento del multilateralismo e lo sviluppo della cooperazione internazionale.
Abbiamo inoltre discusso specificamente delle relazioni dell'UE con l'America latina, che non ha ancora il peso che merita nella politica estera dell'UE, e con gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Quest'ultima è stata citata come elemento centrale in occasione di quasi tutte le sessioni. È davvero impossibile riassumere qui tutti questi dibattiti o menzionare tutti i partecipanti, tra i quali deputati al Parlamento europeo come Reinhard Bütikofer ma anche professionisti e esponenti del mondo accademico come Ricardo Hausmann, Ivan Krastev, Andrey Kortunov, Alina Polyakova, Anne-Marie Slaughter e Carmen Claudin, per citarne solo alcuni.
Geopolitica della pandemia
Non sorprende che la geopolitica della pandemia, la questione della disparità di accesso ai vaccini e l'efficacia del sostegno ai paesi meno sviluppati siano stati molto presenti in tutti i dibattiti. Da parte sudamericana e africana sono arrivate critiche in relazione alla grande differenza tra i tassi di vaccinazione dei paesi ricchi e quelli dei paesi poveri. L'Europa sta facendo molto a tale riguardo, soprattutto finanziando l'iniziativa COVAX, ma le nostre azioni spesso non hanno la stessa visibilità degli interventi diretti come quelli di Cina e Russia. L'UE ha esportato metà della sua produzione di vaccini, ma dobbiamo certamente donare più vaccini ai paesi a basso reddito, come ha recentemente proposto la presidente della Commissione. È importante tuttavia tener presente che i vaccini acquistati collettivamente tramite la Commissione non sono di proprietà di quest'ultima bensì degli Stati membri. Spetta agli Stati membri, in relazione a qualsiasi impegno collettivo a donare una determinata quantità di vaccini, decidere quanti donarne, a quale paese e quando.
Un dibattito franco e utile
In conclusione: la riflessione aperta e franca della settimana scorsa sulle principali sfide geopolitiche per l'Europa, svolta da un gruppo altamente qualificato di oratori assieme a un pubblico di partecipanti molto motivati, è stato un contributo utile e stimolante al dibattito sul futuro dell'Europa. Sono grato a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa iniziativa.
https://twitter.com/eu_eeas/status/1419924966418653186
https://twitter.com/eu_eeas/status/1421165900447760385
Altri post dal blog di Josep Borrell, alto rappresentante dell'UE
MORE FROM THE BLOG

"Una finestra sul mondo"- Blog dell'AR/VP Josep Borrell
Blog di Josep Borrell sulle sue attività e la politica estera europea. Contiene anche interviste, op-eds, una selezione di discorsi e video.